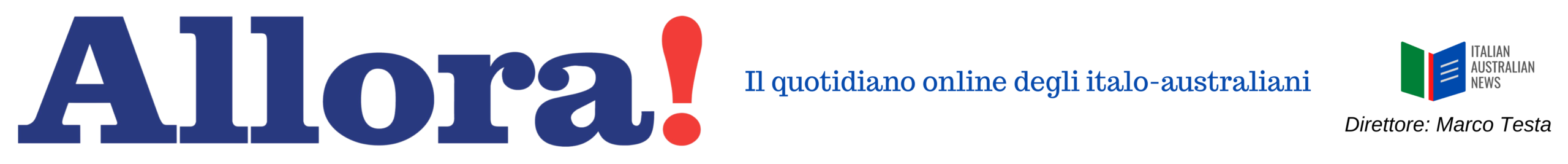Liberamente ispirato dagli scritti di Franco Baldi
È l’11 settembre del 1973. Nel Palacio de La Moneda di Santiago del Cile, Salvador Allende si guarda intorno e si accorge che qualcuno non ha obbedito ai suoi ordini. Miria Contreras, la sua segretaria personale conosciuta con il soprannome di “Payita”, è ancora accanto a lui. Eppure il presidente era stato chiaro: le donne dovevano uscire. Tutte. Lei lo guarda con preoccupazione e fedeltà. Le esplosioni fanno tremare le pareti, sembra l’Apocalisse, la fine di un mondo che è durato troppo poco.
Nella stessa stanza del palazzo presidenziale ci sono anche lo scrittore Luis Sepúlveda e buona parte del Gap – Grupo de Amigos Personales. Gli sguardi di tutti convergono su Allende per l’ultimo ordine: “Uscite e salvatevi. Io resto qui”. Stavolta a nessuno è permesso controbattere, nemmeno alla Payita. Qualcuno supplica, chiede al presidente – perché per loro è e sarà sempre il presidente – di fuggire, di accettare le condizioni del traditore Pinochet. Con un’occhiata la fierezza di Allende sovrasta per un attimo anche il boato delle bombe: tutti capiscono. Escono. Il presidente resta da solo nell’ufficio, in compagnia del frastuono oltre le finestre, della paura della fine e del regalo di un vecchio amico, il mitra AK-47 di Fidel Castro.
Allende lo solleva, lo osserva con mani ferme, come se stesse valutando ogni scelta non come un atto di violenza ma come un gesto di dignità. La luce del pomeriggio entra dalle ampie finestre e gioca sulle mappe del Cile sparse sul tavolo, sui documenti ancora intatti e sugli appunti presi in settimane di lotta politica. Ogni foglio, ogni riga, racconta la storia di un progetto che il golpe sta cercando di cancellare. Il presidente sa che non ci sarà un’altra occasione: quella stanza, quell’ora, sarà l’epilogo della sua presidenza e, forse, della sua vita.
Dall’altro lato della città, le truppe di Pinochet avanzano con precisione e ferocia. Le strade sono piene di militari armati, carri armati e veicoli blindati. I telefoni squillano incessantemente, ma nessuno risponde: il Palacio è isolato, la comunicazione tagliata. I giornali, nelle edizioni già pronte, parlano di “necessità di ordine e stabilità”, mentre nei quartieri operai e universitari si respira panico, confusione, rabbia. I cileni che hanno sostenuto Allende sanno che sta succedendo qualcosa di irreparabile.
Allende ripensa a ogni decisione presa. Dal giorno della sua elezione nel 1970, il suo sogno era stato chiaro: trasformare il Cile in una nazione più giusta, ridurre le disuguaglianze, dare voce ai più deboli. Ogni scelta economica, ogni riforma sociale, era stata ponderata e portata avanti con tenacia. Ora tutto si riduce a minuti, secondi. Sa che Pinochet non si fermerà. Sa che la brutalità non conosce pietà. Eppure, c’è una calma lucida nei suoi occhi, una serenità che deriva dalla consapevolezza di aver dato tutto per il suo paese.
Lentamente, Allende si sposta tra i mobili del suo ufficio, guardando fotografie di famiglia e regali ricevuti da amici e leader mondiali. Tra questi, il mitra donato da Fidel Castro, simbolo di solidarietà internazionale, ma anche di un mondo diviso e ideologicamente conflittuale. Non ha paura del gesto finale, sa che è inevitabile. La storia lo giudicherà, ma lui sa di aver agito con coerenza.
Le esplosioni continuano, i rumori dei tank e dei soldati sono sempre più vicini. Allende chiude gli occhi un attimo, immaginando Santiago, le colline che la circondano, la gente che lavora nei mercati, negli uffici, nei campi. Pensa ai cileni che hanno creduto in lui, che hanno messo fiducia nelle riforme sociali, nelle politiche di salute pubblica, nelle scuole e negli ospedali gratuiti. Sa che molti saranno spaventati, altri traditi, altri ancora troveranno la forza di resistere in futuro.
Mentre la polvere e il fumo entrano dalle finestre, Allende impugna il mitra, ma non lo fa per uccidere. Lo fa per affermare il diritto di resistere, anche se la resistenza è simbolica. Si avvicina alla finestra, osserva i carri armati schierati sotto, vede i soldati pronti a eseguire ordini senza conoscere le storie di chi stanno attaccando. È l’epilogo della democrazia cilena, pensa, ma non il tramonto dei sogni di giustizia.
Allende ricorda le parole pronunciate nei suoi discorsi: “Io morirò con la mia coscienza a posto, consapevole di aver servito il mio popolo con onestà e dedizione”. Quella frase, detta anni prima, ora assume il peso di una profezia. Non c’è rimpianto, non c’è disperazione, solo la lucida accettazione di ciò che deve accadere.
Il silenzio cala per un attimo tra un’esplosione e l’altra. Le mani di Allende si stringono attorno al mitra, lo osservano come un testimone della storia che si sta scrivendo. Ogni oggetto nella stanza sembra parlare: la bandiera cilena appesa con orgoglio, le foto dei suoi compagni di lotta, i libri di filosofia e politica che hanno accompagnato anni di riflessione e decisioni. Tutto concorre a creare una scena di dignità e tragedia insieme.
Nel frattempo, fuori dal palazzo, le prime voci dei civili iniziano a filtrare: gente che corre, urla, piange.
Molti cercano di capire cosa stia succedendo, ma le informazioni sono frammentarie, confuse, spesso contraddittorie. I quartieri popolari cercano rifugio, le famiglie si stringono, consapevoli che il golpe ha cambiato per sempre il destino del paese.
Allende si siede alla scrivania, guarda la carta geografica del Cile e con un gesto lento scrive alcune righe su un foglio: un messaggio per il futuro, un testamento morale. Sa che questo foglio potrebbe diventare simbolo di coraggio per chi verrà dopo, per coloro che non hanno potuto combattere con armi ma con idee.
Il rumore delle bombe si fa assordante, eppure in quella stanza c’è una calma irreale. Allende chiude gli occhi un’ultima volta, e nelle sue palpebre scorrono immagini della sua vita: la gioventù passata a studiare politica, la passione per la giustizia sociale, gli incontri con persone che hanno condiviso sogni e battaglie, i momenti di gioia privata accanto alla famiglia. Ogni ricordo è vivido, ogni emozione è intensa.
Quando la porta del Palacio si spalanca per l’ultima volta per i soldati, Allende è pronto. Non c’è paura. Non c’è disperazione. Solo la fermezza di un uomo che sa di dover affrontare il proprio destino senza compromessi. L’ultimo boato scuote le finestre e, con esso, si chiude un capitolo della storia cilena.
L’eco di quel giorno si propaga per anni e decenni. Le immagini del Palacio de La Moneda in fiamme diventano simboli universali di resistenza e sacrificio. Miria Contreras e gli altri testimoni raccontano la fermezza del presidente, la sua lucidità, il suo coraggio. La sua morte non segna la fine delle idee che ha difeso, ma rafforza la memoria storica e l’impegno di chi continuerà a lottare per la giustizia e la democrazia.
Salvador Allende non ha tradito il suo popolo, e anche da quella fine tragica emerge una lezione di integrità, di rispetto per la propria coscienza e di amore per il paese. In ogni documento, in ogni ricordo, in ogni parola scritta dagli storici, il suo nome resta un faro per coloro che credono nella democrazia, nella libertà e nell’umanità.
Quando il silenzio cala finalmente su La Moneda, la città di Santiago sembra trattenere il respiro. Anche tra le macerie e le fiamme, l’immagine di Allende rimane scolpita nella memoria collettiva: un uomo solo nel suo ufficio, in piedi contro la marea della violenza, che ha scelto la dignità sopra ogni compromesso.
E così, l’11 settembre 1973, termina una giornata che avrebbe cambiato il Cile per sempre. Ma nelle menti e nei cuori di chi ha creduto in lui, Salvador Allende continua a vivere, simbolo eterno della lotta per un mondo più giusto.