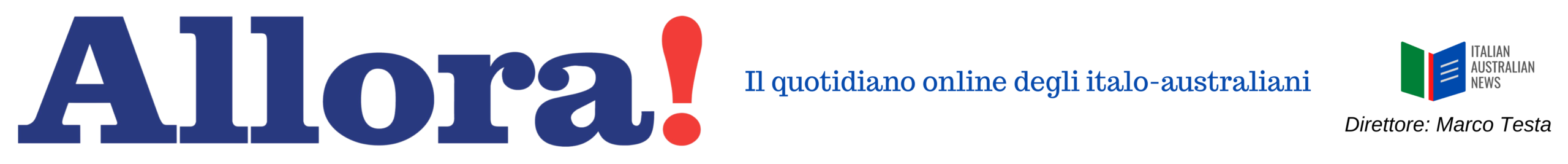di Emanuele Esposito
Dal 24 novembre 2025 l’Italia compie un gesto che, più che una norma, somiglia a un abbraccio tardivo.
Con il nuovo decreto MAECI-Interno-Lavoro, i discendenti dei nostri emigrati nei grandi Paesi della diaspora potranno tornare a lavorare in Italia senza passare per le quote del Decreto Flussi. Un provvedimento atteso, simbolico, inevitabile: per la prima volta lo Stato riconosce che quei milioni di italiani partiti — e i loro figli e nipoti — non appartengono soltanto al passato, ma al presente dell’Italia.
Non è una sanatoria né un privilegio: è un atto di giustizia verso comunità che, per oltre un secolo, hanno mantenuto viva l’identità italiana quando l’Italia non poteva fare altrettanto.
È una norma che parla di radici, sentimento, memoria collettiva. Attua l’art. 27, comma 1-octies del Testo Unico sull’Immigrazione e l’art. 1-bis del DL 36/2025, creando una corsia preferenziale per chi porta un cognome italiano e una storia che comincia con una valigia di cartone.
La scelta dei sette Paesi — Argentina, Brasile, Stati Uniti, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay — rispecchia la geografia storica dell’emigrazione. Sono le grandi patrie degli oriundi, dove l’Italia ha messo radici che hanno generato comunità straordinarie: club, parrocchie, associazioni, dialetti sopravvissuti, feste patronali rinate. Interi mondi italiani fuori dall’Italia.
Che oggi, finalmente, ricevono un segnale: tornate, se volete. Il Paese vi riconosce. Ma non tutti possono rientrare. È la prima ombra di un decreto che, pur necessario, nasce monco. Restano tagliati fuori Paesi come Messico, Perù, Cile e Sudafrica — dove vivono comunità italiane in crescita — perché non superano la soglia dei 100.000 iscritti AIRE.
Una scelta che guarda al passato più che al futuro: la nuova diaspora non vive solo nei “giganti” storici, ma in una mappa globale fatta di seconde occasioni, mobilità professionale, migrazioni contemporanee. L’Italia vive una crisi demografica profonda, e continua a ignorare un capitale umano che altri Paesi ci invidierebbero: giovani bilingui, formati, motivati, già culturalmente affini. Persone che possono inserirsi nel mercato del lavoro con rapidità, senza traumi e senza le incertezze dei click day che umiliano chi tenta di rientrare legittimamente.
Il decreto è una svolta, ma non è una strategia. Se davvero vogliamo recuperare il rapporto con i nostri figli lontani, servono politiche più coraggiose: incentivi al rientro, riconoscimento delle competenze maturate all’estero, programmi di scambio, cooperazione con associazioni e Comites, una rete stabile che trasformi la diaspora in ponte e non in nostalgia. Per decenni abbiamo chiesto rispetto per i nostri emigranti. Ora tocca a noi dimostrare rispetto ai loro discendenti, offrendo non solo un corridoio amministrativo, ma un progetto di Paese che li includa davvero.
Questo decreto racconta un’Italia che comincia — timidamente — a guardare oltre i propri confini.
Ma il futuro richiede qualcosa in più: la consapevolezza che una parte importante dell’Italia vive già fuori dai confini nazionali, parla altre lingue ma porta un cognome che ci appartiene.
E che quel filo, spezzato da milioni di partenze, può essere ricucito solo se scegliamo di rileggerlo come una risorsa, non come un ricordo.