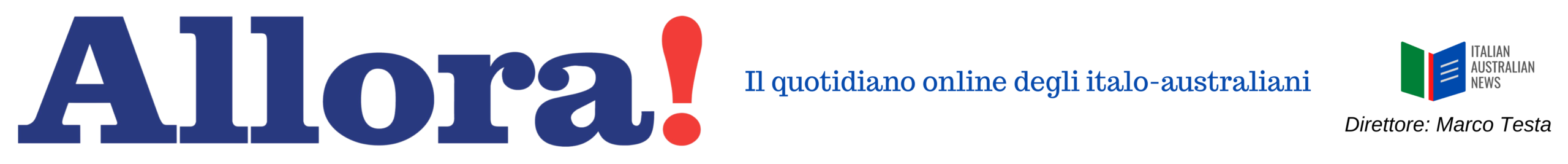di Emanuele Esposito
Non è un accordo tecnico, non è una firma su qualche carta a Bruxelles e non è nemmeno una questione di dazi. L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Australia è una partita politica dura, sporca e profondamente reale. Da una parte c’è l’Europa che difende i propri equilibri interni, il mondo agricolo, il consenso nelle campagne, le lobby storiche che pesano più delle dichiarazioni ufficiali.
Dall’altra c’è l’Australia, che chiede accesso al mercato europeo per carne, zucchero, cereali, materie prime e che non vuole più essere trattata come un partner minore. Il nodo vero è l’agricoltura. Non i diritti, non l’ambiente, non la cooperazione.
La carne australiana fa paura perché è competitiva, perché costa meno, perché arriva da un sistema produttivo che l’Europa non ha mai voluto davvero riformare. E allora si prende tempo, si rinvia, si parla di standard di sostenibilità mentre sotto sotto si difende un sistema che non regge più. Ma questo accordo non riguarda solo le merci. Riguarda il potere, la geopolitica, la necessità europea di ridurre la dipendenza dalla Cina e quella australiana di non restare schiacciata tra Stati Uniti e Asia.
Ed è qui che entra in gioco la mobilità. Non come gesto di apertura, ma come moneta di scambio. La mobilità delle persone diventa la leva politica per sbloccare ciò che sulle merci resta bloccato: meno concessioni sull’agroalimentare, più aperture su visti, lavoro e circolazione delle persone.
La verità è semplice: la libertà di movimento non è un diritto riconosciuto, è una concessione negoziata. Per l’Europa, la mobilità è il prezzo da pagare per proteggere i propri settori sensibili. Per l’Australia, è il modo per attrarre competenze, forza lavoro qualificata, capitale umano europeo. Due interessi diversi, una stessa moneta. Chi racconta questa trattativa come una grande opportunità romantica mente. È un braccio di ferro, un do ut des, è politica nuda. E mentre le merci viaggiano senza passaporto, i cittadini restano fermi ad aspettare come sempre. Dentro questa partita, però, l’agroalimentare italiano non è il bersaglio principale. L’Italia non compete sui volumi, non compete sui prezzi, non compete sulle commodity. Il nostro sistema vive di qualità, trasformazione, valore aggiunto, denominazioni, identità. Vive di vino, formaggi, olio, pasta, conserve, dolciario. Vive di Made in Italy vero, non di massa.Ed è proprio per questo che l’accordo può diventare un vantaggio.
L’Australia è un mercato ricco, stabile, culturalmente vicino, un paese dove il cibo italiano non è esotico ma desiderato. Un paese dove la domanda esiste già ma l’accesso è difficile. Oggi esportare in Australia per molte aziende italiane è costoso, lento, burocratico: certificazioni doppie, controlli ridondanti, costi logistici, barriere indirette. Un accordo di libero scambio può ridurre queste barriere. Non eliminarle, ma renderle affrontabili.
Questo significa più spazio per le PMI italiane, quelle vere, quelle che oggi restano fuori non per mancanza di qualità ma per mancanza di struttura. C’è poi un punto decisivo che vale sia per il cibo sia per le persone: la tutela delle indicazioni geografiche e delle competenze. DOP, IGP, DOC da una parte; titoli, esperienze, professionalità dall’altra. Meno parmesan, più Parmigiano. Meno prosecco finto, più Prosecco vero. Meno visti usa e getta, più percorsi di vita e lavoro reali. Per l’Italia questo vale oro: vale identità, valore, reputazione. Chi dice che l’agroalimentare italiano ha solo da perdere racconta una favola politica.
Serve a difendere rendite interne, non l’interesse nazionale. Serve a proteggere sistemi che producono quantità, non valore. La verità è che l’Italia ha più da guadagnare restando dentro la partita che stando fuori. Perché se l’Europa firma senza di noi, l’Australia troverà comunque altri fornitori e altri lavoratori. E noi resteremo con i principi, i magazzini pieni e i giovani fermi.
Il rischio vero non è l’accordo, è l’inerzia. È non fare sistema, è lasciare campo libero all’italian sounding e alla fuga disordinata delle competenze. È non accompagnare imprese e persone con una diplomazia economica e sociale seria. Questo non è solo un problema commerciale: è un problema politico. In un mondo che cambia, chi vive di qualità o si apre o scompare. E se l’Italia gioca bene questa partita, non vende solo cibo e non esporta solo persone.
Vende identità, territorio, cultura, competenze. Su questo, l’Australia non è un nemico: è un mercato e un paese pronti ad ascoltare, se finalmente abbiamo qualcosa di serio da offrire.