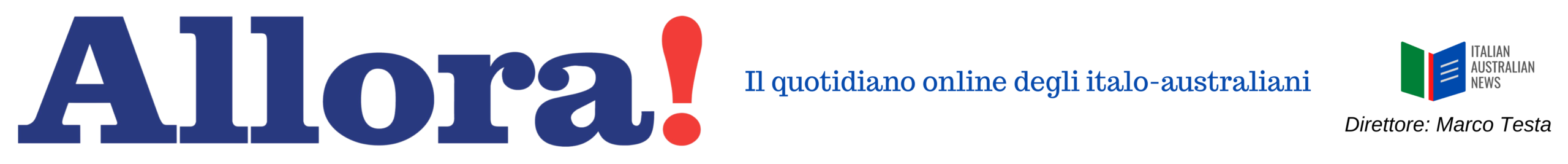La strage di Bondi ha segnato un prima e un dopo nella storia recente dell’Australia. Non è stata soltanto un atto di violenza terroristica di proporzioni senza precedenti, ma un evento che ha fatto emergere con brutalità fratture profonde, paure latenti e contraddizioni che il Paese preferiva non guardare in faccia. Di fronte a un trauma collettivo di questa portata, la tentazione più diffusa è rifugiarsi nelle formule rassicuranti: condanna dell’odio, appelli all’unità, dichiarazioni di principio. Tutto necessario, ma drammaticamente insufficiente. Oggi la domanda non è se l’Australia sia una società multiculturale – lo è – ma che tipo di multiculturalismo intenda difendere e trasmettere alle generazioni future.
Per decenni, il multiculturalismo australiano è stato presentato come un modello virtuoso, capace di coniugare diversità culturale e coesione sociale. Milioni di migranti hanno trovato in Australia una nuova casa, attratti non solo dalle opportunità economiche ma anche da un quadro di valori condivisi: libertà individuali, stato di diritto, uguaglianza davanti alla legge, separazione tra sfera religiosa e sfera civile. Questo “collante” non era etnico né confessionale, ma profondamente politico e culturale. Era l’idea che persone diverse potessero convivere pacificamente perché legate da principi comuni più forti delle differenze.
Negli ultimi anni, però, questo equilibrio si è progressivamente indebolito. La difesa dei valori universali è stata spesso sostituita da una narrazione che esalta le identità di gruppo come elementi intoccabili. La diversità è diventata un fine in sé, non più una ricchezza da integrare dentro un progetto condiviso. In nome del rispetto, si è spesso rinunciato al confronto; per paura di offendere, si è smesso di discutere. Il risultato è un multiculturalismo fragile, che evita le domande difficili e lascia spazio a incomprensioni, radicalizzazioni e risentimenti reciproci.
La strage di Bondi ha reso evidente il costo di questa reticenza. Oggi una parte della popolazione australiana – la comunità ebraica – vive con la sensazione concreta di non essere più al sicuro nello spazio pubblico. Celebrazioni religiose, eventi comunitari, persino momenti di lutto richiedono misure di sicurezza straordinarie. Allo stesso tempo, australiani palestinesi e musulmani temono di essere stigmatizzati o di subire ritorsioni per colpe non loro. Questa doppia paura è il segnale più chiaro che il patto sociale si è incrinato.
In questo contesto, limitarsi a dire “no all’odio” rischia di diventare una scorciatoia morale. È una posizione che mette tutti d’accordo, ma che non spiega nulla e non risolve nulla. L’odio non nasce nel vuoto: cresce dove mancano riferimenti chiari, dove le parole vengono svuotate di significato e dove le istituzioni rinunciano a esercitare una leadership culturale. Riflettere sul futuro del multiculturalismo significa, prima di tutto, riconoscere che la neutralità apparente non è neutrale: spesso favorisce le voci più estreme e rumorose.
Negli ultimi mesi, le grandi manifestazioni legate al conflitto in Medio Oriente hanno mostrato quanto sia difficile gestire le tensioni globali importate nello spazio nazionale. Molti partecipanti hanno espresso una solidarietà sincera verso le vittime civili e una critica legittima alle politiche dei governi. Tuttavia, accanto a queste istanze, sono emersi slogan e simboli che evocano violenza, annientamento e terrorismo. Espressioni come “globalizzare l’intifada” o slogan che negano implicitamente il diritto all’esistenza di Israele non possono essere liquidati come semplici opinioni politiche, soprattutto in un contesto segnato da attentati e odio antiebraico.
Il nodo centrale non è la libertà di protesta, che resta un pilastro della democrazia, ma la responsabilità che accompagna la libertà di parola. Tutto può essere detto senza conseguenze? Ogni slogan è innocuo se pronunciato da chi sostiene di non conoscerne il significato storico o simbolico? In una società multiculturale matura, queste domande non dovrebbero essere tabù. Al contrario, dovrebbero essere affrontate apertamente, proprio per evitare che l’ambiguità alimenti paura e radicalizzazione.
Un multiculturalismo sostenibile non può fondarsi sull’idea che tutte le culture e tutte le pratiche siano ugualmente compatibili con i valori democratici. Questo non significa gerarchizzare le persone, ma valutare le idee. Dottrine religiose o ideologiche che giustificano la violenza, promuovono l’odio verso ebrei, donne, omosessuali o “infedeli” sono incompatibili con ciò che ha reso l’Australia una società aperta e attrattiva. Riconoscerlo non equivale a criminalizzare intere comunità: la stragrande maggioranza dei musulmani australiani, ad esempio, rifiuta queste visioni estremiste. Ma ignorare il problema per timore di sembrare intolleranti significa abbandonare il terreno del confronto a fanatici e demagoghi.
C’è poi un altro aspetto che la strage di Bondi ha portato alla luce: il senso di insicurezza culturale di una parte della popolazione. Molti australiani, non necessariamente ostili all’immigrazione, esprimono preoccupazioni su integrazione, coesione sociale e rapidità del cambiamento demografico. Quando queste inquietudini vengono sistematicamente liquidate come razziste o ignoranti, non scompaiono: si radicalizzano. E finiscono per essere intercettate da forze politiche populiste che offrono risposte semplici a problemi complessi.
Se il dibattito pubblico rinuncia a occuparsi seriamente di immigrazione, identità nazionale e valori comuni, altri lo faranno al posto suo. La storia recente dimostra che quando i liberali smettono di difendere i principi liberali, gli illiberali sono pronti a proporsi come difensori dell’ordine e della sicurezza, spesso a scapito delle libertà fondamentali. È un rischio reale, non teorico.
Riflettere sul futuro del multiculturalismo significa anche riconoscere che esso comporta obblighi reciproci. Alla maggioranza è richiesto uno sforzo di apertura: accettare il disagio dell’alterità, confrontarsi con lingue, fedi e costumi diversi, rinunciare all’illusione di un’identità monoculturale. Ma alle minoranze è richiesto qualcosa di altrettanto impegnativo: accettare che vivere in Australia implica il rispetto di valori condivisi, la rinuncia a dogmatismi importati, il rifiuto di conflitti lontani come strumenti di mobilitazione locale.