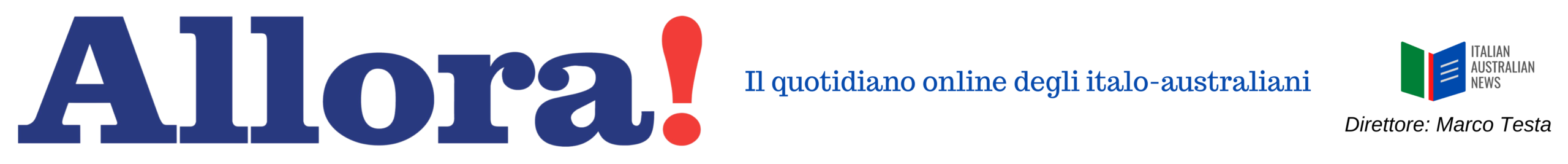di Lorenzo Canu
In occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto, si è tenuto presso l’Istituto Italiano di Cultura di Sydney “Gerarchia e privilegio”, melologo per voce e pianoforte con musiche di Claudio Rastelli, interpretato da Diana Höbel (voce) e Federico Nicoletta (pianoforte).
L’opera è una riflessione sulla struttura e le dinamiche dei campi di sterminio, costruita interamente sulle citazioni dirette di Primo Levi e Hermann Langbein.
Ha aperto l’evento il Direttore dell’Istituto, Marco Gioacchini, ricordando che “Gerarchia e privilegio” è “un’ammonizione e una testimonianza di uno dei punti più bassi mai raggiunti nella storia dell’umanità, e può servire per cercare di evitare di commettere gli stessi errori”.
Ho sempre avuto una visione binaria dell’Olocausto: vittime e carnefici. Lo spettacolo ha rivelato qualcosa di più complesso e disturbante – le gerarchie interne ai campi, dove per la più piccola particola di potere i prigionieri erano disposti a tradirsi reciprocamente, a farsi violenza gli uni con gli altri.
Dai vari materiali raccolti e presentati è infatti emersa una visione complessa dei campi come luoghi infernali ma organizzati secondo “principi” che possono essere ancora riconosciuti nelle nostre società odierne: paura, gerarchia e privilegio, il rovesciamento dell’imperativo categorico kantiano, trattando gli esseri umani come un mezzo e non come un fine.
Nei suoi scritti, Levi citò le ricerche dell’etologo Konrad Lorenz sui ratti, spiegando come questi si dividano in “tribù”. Così come quelli della cantina sono una realtà a sé stante, così lo sono quella della cucina e del solaio. E queste, tra di loro, non si riconoscono. Anzi, si respingono. Si fanno a pezzi. «Non si può fare a meno di pensare all’immigrato che, finché non ha acquistato non dico l’odore, ma l’accento del paese in cui si è stabilito, viene riconosciuto come diverso. Non viene fatto a pezzi, di solito, per nostra fortuna ma viene riconosciuto come diverso, e viene emarginato, viene ostacolato», dice Levi.
Fin dalla fine della guerra, Hannah Arendt è stata l’autrice chiave per comprendere l’Olocausto con il suo concetto di “banalità del male” e la routinizzazione burocratica della crudeltà.
Oggi, temo, l’autrice di riferimento potrebbe dovrebbe essere Susan Sontag, che descrive come l’esposizione costante a immagini di sofferenza – guerre, genocidi, catastrofi – crei una pericolosa assuefazione. Viviamo immersi in un flusso incessante di atrocità che si sovrappongono e si cancellano nel ciclo mediatico.
Il rischio è la relativizzazione reciproca: quando tutto viene presentato con la stessa urgenza apocalittica o quando le tragedie presenti vengono usate per negare quelle passate, perdiamo la capacità di riconoscere la gravità assoluta di ciascun evento. L’orrore dell’Olocausto non dovrebbe essere né diminuito né strumentalizzato – e viceversa, le sofferenze di oggi non possono essere minimizzate dal peso della storia. Non per buonismo, quanto piuttosto come esercizio di com-plessità. Due cose possono essere vere allo stesso tempo, e possiamo ricordare senza strumentalizzare, vedere i paralleli senza appiattire le differenze.
Scrive Nicoletta prima dell’evento: “per me, partecipare a questo lavoro significa restare in una zona scomoda, abitare l’inquietudine di farsi domande, di non sentirsi acriticamente dalla parte dei buoni, di continuare a vedere come funzionano, ancora oggi, i dispositivi che regolano appartenenza ed esclusione.”
Per questo, ascoltare Levi e Langbein in silenzio – con lo stesso silenzio che abbiamo sentito la prima volta che abbiamo conosciuto l’Olocausto – diventa forse un atto di resistenza alla desensibilizzazione.
È scegliere di dare ancora peso alle cose, a tutte le cose, nella loro gravità specifica e irriducibile. E a Sydney, dopo Bondi, lo sappiamo troppo bene.