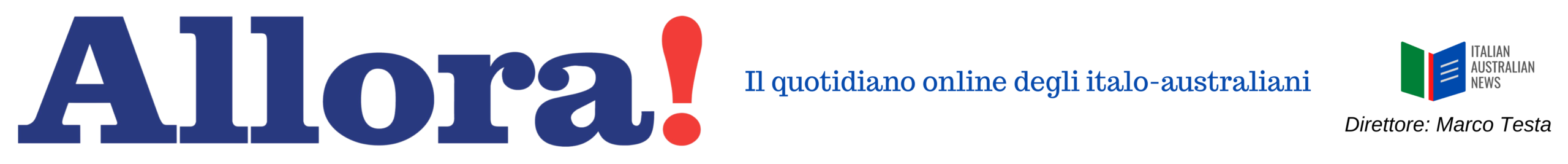di Marco Zacchera
Questo numero de IL PUNTO è diverso dal consueto e l’ho scritto già diversi giorni fa, prima della mia partenza. In questi giorni sono infatti lontano dall’Italia e voglio spiegarvi il perché.
Qualche lettore forse ricorda che dal 1981 ho fondato e mi occupo dei Verbania Center che, con l’aiuto di molte persone, cercano di dare una mano concreta in diverse parti del mondo, dall’Africa al Myanmar, dal Sudamerica al Mozambico. Come di consueto a fine novembre manderò il solito report annuale di quanto è stato realizzato quest’anno.
Questa volta, però, il viaggio che sto svolgendo in Sudamerica è diverso dagli altri perché sto andando a trovare Pacho, un amico vero e con il quale sono in contatto da oltre 40 anni.
Lo conobbi a Loyangallany, in una sperduta missione cattolica nell’estremo nord del Kenya sulle rive del grande lago Turkana, dove cercavo con molte difficoltà di insegnare a pescare ad una tribù locale, quella gli Ol Molo (che in samburu significa “poveri diavoli senza vacche”) concretamente fedele al motto che – anzichè regalare un pesce – è molto meglio insegnare a pescarlo.
Andavo a Loyangallany quasi ogni anno e Pacho era il viceparroco della comunità, giovanissimo missionario della “Consolata” spedito dai suoi superiori direttamente da Roma a fare esperienza sul campo in quel luogo così difficile e lontano.
A 650 chilometri da Nairobi, Loyangallany era (ed è) una piccola oasi in mezzo a un deserto che finisce nel lago, dove di giorno e di notte la temperatura è sempre opprimente e pazzesca. Ci si arriva dopo due giorni di viaggio in fuoristrada o in aereo, ma solo in caso di emergenza, atterrando su una pista approssimata.
Ci conoscemmo a fondo durante quelle lunghe serate africane chiacchierando sotto quel cielo sempre limpido e pieno di stelle, così diverse e luminose dalle nostre. Iniziò così la nostra lunga amicizia riconoscendo che già da allora Pacho aveva una profondità e serenità unica nell’affrontare i problemi della modernità del mondo e dei necessari cambiamenti della Chiesa, pur ancorandosi sempre e senza deflettere ai più solidi principi della Fede.
“Cresceremo insieme” ci dicevamo scherzando fra noi e fu davvero un po’ così: io nella politica lui nella sua missione pastorale avviando poi insieme anche diversi progetti in Kenya e in Colombia.
Fu infatti poi richiamato in Italia – parla un italiano perfetto – e inviato in Sudamerica (lui è colombiano) per incarichi sempre più importanti finché, l’11 febbraio 1999, fu consacrato vescovo nella antica cattedrale di Santa Fe di Bogotà.
Ricordo una cerimonia lunghissima e solenne – presieduta dal cardinale Tomko – in quella enorme chiesa barocca un po’ buia, tra canti e preghiere in latino, spagnolo e in vari dialetti indigeni. La comunità di Pallanza – dove lui è venuto diverse volte – gli donò per l’occasione la mitra con il simbolo dell’imminente giubileo del 2000 e lui volle indossarla proprio quel giorno. Ero venuto apposta dall’Italia per salutarlo e furono davvero giorni intensi.
Lo mandarono subito a guidare una sperduta, nuova diocesi del Rio delle Amazzoni a San Vicente de Caguan tra fiumi e foreste, dove il vescovo lo fai a dorso di mulo e soprattutto in barca. La guerriglia, per festeggiare il suo arrivo, rapì tutti i chierici del seminario liberandoli solo diversi giorni dopo, tanto per far capire chi comandava da quelle parti. Eppure Pacho (che ormai era per tutti mons.
Francisco Javier Munera) seppe farsi apprezzare anche come fine diplomatico, tanto che il territorio della sua diocesi divenne presto una zona smilitarizzata dove cominciarono le trattative tra governo colombiano e le FARC che si conclusero nel 2001 con il disarmo consensuale della guerriglia.
Dal 2021 mons. Munera è poi stato nominato arcivescovo di Cartagena de Indias, la cattedrale primaziale della Colombia, e Pacho è anche diventato l’anno scorso fino al 2027 presidente della Conferenza Episcopale colombiana.
Certo non è più quel ragazzo magro con i capelli neri ed ispidi, anche lui si avvicina ormai ai 70 anni, ha la barba quasi tutta bianca e porta con discrezione la croce episcopale, ma per me (e per chi lo ha conosciuto in Kenya) è e resterà sempre “Pacho”. Credo che questa volta svilupperemo un progetto di assistenza per i ragazzi di strada di quella città già avviato qualche tempo fa, ma questo potrò raccontarvelo la prossima volta.
Per intanto scusatemi se mancherò per un venerdì a commentare le cronache, ma sono convinto che avrete capito il perché condividendo che “queste” sono le cose davvero importanti. Vi saluterò Pacho: anche lui riceve Il Punto, ma credo che raramente abbia il tempo di leggerlo!