
Dal 1876 al 1915 furono 14 milioni gli italiani che, armati solo di speranza e di una valigia di cartone, lasciarono tutto per cercare fortuna altrove. E se durante i primi 10 anni il viaggio fu più semplice perché la meta preferita era l’Europa, dal 1886 gli italiani iniziarono a imbarcarsi per raggiungere l’America; nei quarant’anni di massiccia emigrazione, 7 milioni e 600mila italiani attraversarono l’Atlantico per giungere prima in Argentina e poi anche in Brasile, Stati Uniti e, cambiando rotta, anche in Australia.
La traversata era effettuata, presumibilmente, in condizioni anche peggiori di quelle che oggi gli immigrati vivono sui barconi in partenza dalla Libia con direzione Lampedusa.
Le cattive condizioni delle navi utilizzate per il trasporto della “tonnellata umana”, come era chiamato il carico degli emigranti, anche un secolo fa provocarono frequenti disastri come quelli che accadono oggi al largo della Libia.
Presso il Museo Nazionale dell’Emigrazione è riportato che nel piroscafo “Città di Torino”, a novembre del 1905, ci furono 45 morti su 600 imbarcati; sul piroscafo “Matteo Brazzo” nel 1884, si contarono 20 morti per colera su 1.333 passeggeri; sulla nave “Carlo Raggio” nel 1888 ci furono 18 morti per fame e nel 1894 ne morirono 206 per malattia; sempre nel 1888 sul “Cachar” 34 emigranti morirono di fame e soffocamento; sulla nave “Friesland” nel 1889, furono 27 i morti per soffocamento e oltre 300 si ammalarono; sulla nave argentina “Parà”, nel 1889, 34 emigranti morti per morbillo; sulla nave “Remo”, nel 1893, furono 96 i morti per colera e difterite; sull’Andrea Doria, nel 1894 con 1.317 emigranti, ne morirono 159; sulla “Vincenzo Florio”, 1894, ancora 20 morti.
Il 17 marzo 1891, nel naufragio dell’Utopia, al largo del porto di Gibilterra, morirono 576 italiani; il 4 luglio 1898, si contarono 549 morti nella tragedia della “Borgogna” al largo della Nuova Scozia; il 4 agosto 1906, nel naufragio della “Sirio” in Spagna, le vittime italiane furono 550.
Il 25 ottobre 1927 al largo delle coste del Brasile, con l’affondamento del piroscafo “Principessa Mafalda” avvenne il disastro peggiore per gli emigranti italiani. Varato il 22 ottobre 1908 ed entrato in servizio il 20 marzo 1909, era l’ammiraglia della flotta italiana dei Lloyd’s e il piroscafo tricolore più prestigioso.
In occasione dell’ultimo viaggio, la nave aveva lasciato Genova l’11 ottobre 1927, al comando di Simone Gulì, esperto comandante sessantaduenne di Napoli ma di origini siciliane, con a bordo 1.259 persone, tra cui una minoranza di emigranti siriani e, soprattutto, numerosi piemontesi, liguri e veneti. Avrebbe dovuto essere, in ogni caso, l’ultimo viaggio del transatlantico prima del suo smantellamento poiché, dopo anni di usura e scarsa manutenzione, il piroscafo non era più considerato sicuro dagli addetti ai lavori e dallo stesso comandante Simone Gulì. Tuttavia tuttavia secondo la società armatrice, la nave era ancora in buone condizioni e poteva ancora godere del prestigio di un tempo. Malgrado ciò, durante il viaggio si verificarono innumerevoli contrattempi prima del tragico epilogo.
Tant’è che solo nel tratto mediterraneo a Gibilterra, la nave subì 8 avarie al motore, uno alla pompa d’aspirazione, uno all’albero di trasmissione sinistro e un altro nelle celle frigorifere, al punto da costringere il comandante Gulì a fermare i motori ben otto volte, nel solo tratto tra Genova e Barcellona.
La tappa nello scalo spagnolo si prolungò per ventiquattro ore; ciò per consentire la riparazione di una pompa di aspiratore che si era guastata; poi la navigazione riprese alla volta dell’arcipelago di Capo Verde ma, a due ore dallo stretto di Gibilterra, subentrò un nuovo guasto costringendo il piroscafo a navigare con il solo motore di dritta.
Lasciato il Mediterraneo, si guastò anche il motore di sinistra e quindi si procedette alla ricerca dell’avaria, lasciando il piroscafo a motori spenti per circa sei ore. Riparato il guasto, il “Principessa Mafalda” ripartì con il solo motore di sinistra, navigando lievemente inclinato a sinistra e a velocità ridotta per un giorno intero.
Si rese dunque necessaria una tappa non prevista al porto di Dakar per effettuare la riparazione all’asse dell’elica sinistra. Il 18 ottobre, dopo la partenza da Dakar, si dovette effettuare un’altra tappa forzata di quasi ventiquattro ore presso lo scalo di São Vicente, per riparare le celle frigorifere che, guastatesi durante la navigazione, avevano fatto deperire le scorte di alimenti e di carne, provocando, anche, principi di intossicazione ai passeggeri.
Dopo aver navigato nell’Atlantico, nonostante il capitano, a causa delle costanti vibrazioni del motore sinistro, avesse chiesto invano alla compagnia di trasferire i passeggeri su un altro transatlantico, il 25 ottobre la nave era a 80 miglia di distanza al largo delle coste del Brasile, tra Salvador de Bahia e Rio de Janeiro.
Il piroscafo “Principessa Mafalda” avanzava a velocità ridotta e visibilmente inclinato verso sinistra, quando alle 17:10 si percepì un forte impatto: l’albero di trasmissione sinistro era scivolato e, continuando a ruotare per inerzia, aveva provocato un grosso infortunio al casco. E l’acqua, dopo aver allagato la sala macchine, invase anche la cantina perché le porte-stagno non funzionavano a dovere.
Una volta lanciato l’SOS, le navi che erano prontamente accorse, si fermavano ad una certa distanza, temendo che la caldaia a vapore della nave italiana potesse esplodere; tra l’altro, non era possibile informarle che il pericolo era stato evitato, aprendo le valvole del vapore, perché l’unico generatore di corrente a bordo era stato danneggiato dall’acqua rendendo fuori uso il telegrafo.
Poco dopo le ore 22, quando la nave rimase completamente buia, a bordo scoppiò il panico: il comandante fece abbassare le scialuppe di salvataggio ma, a causa dell’inclinazione a sinistra, quelle di tribordo urtarono lo scafo che crollò. Molti passeggeri si tuffarono cercando di nuotare verso le scialuppe di salvataggio e alcuni di loro furono mangiati da squali mentre altri si suicidarono, sparandosi, per evitare di annegare.
Nelle false notizie che si diffusero fu comunicato che le “poche decine di vittime” erano da contare soltanto tra gli ufficiali dell’equipaggio e i passeggeri della Prima classe. A confermare questa versione e ad attaccare la stampa estera che affermò il contrario fu l’ambasciatore italiano in Argentina, Attolico, che rilasciò un’intervista al Corriere Mercantile in cui pose l’accento sull’«eroico contegno dell’equipaggio nel terribile frangente» e in cui affermò che, comunque, sarebbe seguita un’indagine sulla sciagura per ordine dello stesso Mussolini.
Malgrado ciò, la tragica notizia fu liquidata definitivamente dall’allora ministro delle Comunicazioni, Costanzo Ciano, che emanò un breve comunicato in cui dichiarò che la nave, alla partenza, era in perfetta efficienza e insistendo che quanto accaduto era da attribuirsi unicamente al fato avverso; infine, il governo italiano conferì meritatamente la medaglia d’oro alla memoria al comandante Gulì, che diresse le operazioni di evacuazione fino a farsi seppellire con la nave nell’oceano, e agli ufficiali: il direttore di macchina Scarabicchi e i marconisti Reschia e Boldracchi.
Secondo i dati ufficiali forniti dalle autorità italiane che minimizzarono il disastro, parlando inizialmente di poche decine di vittime solo tra l’equipaggio, i morti furono 314, ma i sudamericani diedero un numero di morti maggiore del doppio: 657. Ancora oggi, però, non è chiaro quanti immigrati italiani persero la vita a bordo delle “carrette del mare” in cui si erano imbarcati sognando un futuro migliore.
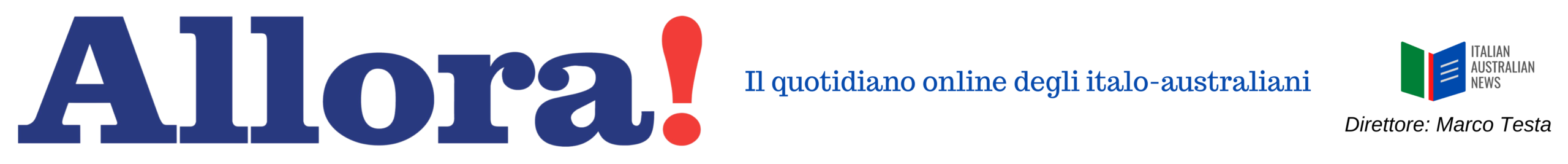



Be the first to comment