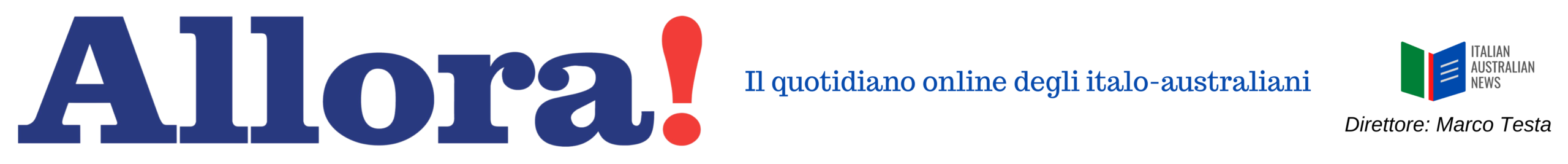Di Emanuele Esposito
Quando un capo di governo decide di scendere sul terreno delle offese personali, la diplomazia non è più solo incrinata: è in frantumi.
Benjamin Netanyahu, definendo Anthony Albanese un “politico debole” che avrebbe “tradito Israele e abbandonato gli ebrei australiani”, non ha semplicemente reagito a una scelta politica di Canberra — il riconoscimento dello Stato palestinese — ma ha lanciato un segnale di allarme al mondo intero. La decisione del governo Albanese di riconoscere formalmente la Palestina non arriva dal nulla: è il frutto di un dibattito internazionale che vede sempre più paesi, in particolare in Europa e nell’emisfero sud, spingere verso un riequilibrio della posizione storicamente filo-israeliana.
L’Australia non fa eccezione. Per Netanyahu, però, questa mossa non è stata percepita come una semplice presa di posizione politica, bensì come un “tradimento”.
Il linguaggio usato dal premier israeliano ha il sapore dell’ira e della disperazione: segnale che Israele teme l’erosione progressiva del fronte degli alleati tradizionali, proprio mentre la guerra a Gaza ha logorato la sua immagine internazionale. Una diplomazia fondata sulla retorica del nemico rischia di isolare ancora di più Israele, che oggi appare in difficoltà nel contenere le critiche persino da parte degli storici partner occidentali.
Non è la prima volta che Netanyahu sceglie il registro dell’attacco personale. Lo ha fatto con altri leader occidentali, e la tattica è chiara: spostare l’attenzione dal merito delle scelte alla credibilità di chi le compie. Definire un capo di governo “debole” è un’arma che serve a galvanizzare la propria base interna, ma rischia di produrre danni irreversibili sul piano diplomatico.
Dall’altra parte, Anthony Albanese non ha reagito con la stessa durezza. Ha scelto la linea della calma, del non prendere “sul personale” le parole di Netanyahu.
Una mossa accorta, che lascia intendere come l’Australia voglia mantenere il profilo istituzionale, senza trasformare un confronto di visioni in una rissa da social network. In un contesto internazionale già saturo di conflitti verbali, la sobrietà australiana appare come un tentativo di salvaguardare la credibilità politica, più che un atto di debolezza.
In questo scontro si inserisce la posizione scomoda della comunità ebraica australiana. Da una parte, il timore che il riconoscimento della Palestina venga percepito come un abbandono.
Dall’altra, la consapevolezza che le relazioni tra i due Paesi non possono essere ridotte a un gioco di insulti reciproci. Persino l’Executive Council of Australian Jewry ha criticato la scelta dei toni, invitando entrambi i leader a ritrovare la via del dialogo “dignitoso”.
Il vero punto politico non è tanto lo scambio di accuse, ma la rottura di un equilibrio che durava dal 1948.
Israele e Australia erano state alleate costanti, con una linea di cooperazione sicura anche nei momenti più bui del Medio Oriente. Oggi, invece, la decisione di Canberra e la reazione di Gerusalemme rischiano di creare un solco profondo, che non si chiuderà facilmente.
La diplomazia si regge sulle parole. Ma quando le parole diventano insulti, i ponti bruciano in fretta. Netanyahu, nel definire Albanese un politico “debole”, ha forse parlato più ai suoi elettori interni che al mondo.
Albanese, scegliendo la compostezza, ha invece cercato di mantenere il tono della statura istituzionale.
La domanda è: in questa guerra di parole, chi pagherà il prezzo più alto? Israele, rischiando l’isolamento, o l’Australia, accusata di aver “tradito”?
Una cosa è certa: la storia ricorderà meno gli insulti e più le scelte. E la scelta australiana segna una svolta che Netanyahu non potrà cancellare con un post su X.