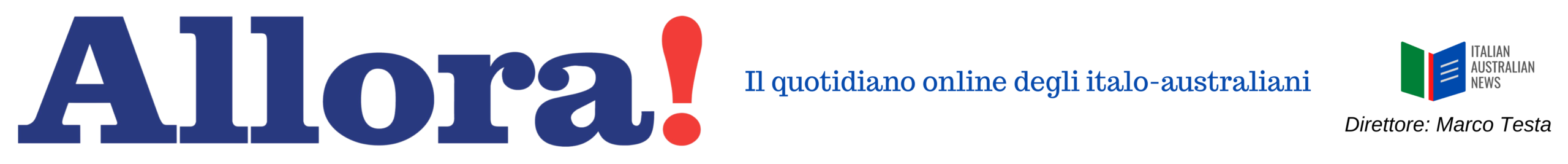Il Negli ultimi anni si è assistito a un proliferare di fondazioni, premi e borse di studio intitolati a persone care: amici, parenti, spesso scomparsi da poco, ai quali si vuole dedicare più di una targa o un ricordo familiare. Queste iniziative nascono quasi sempre sull’onda emotiva di un lutto, come atto d’amore e desiderio di lasciare un’impronta positiva per la collettività. Tuttavia, dietro l’apparente generosità si cela una questione meno nobile: il tentativo, più o meno consapevole, di scolpire il proprio nome o quello della propria cerchia familiare nella memoria pubblica. L’ironia di questo fenomeno non sfugge: l’omaggio rischia di sconfinare nell’autocelebrazione.
La riflessione diventa ancora più pungente se osserviamo come è cambiato il senso della memoria tra le generazioni. I nostri nonni, emigrati del dopoguerra, hanno lasciato segni tangibili nei paesi di arrivo: hanno costruito case, scuole, chiese e club, spinti da autentico spirito comunitario e dal bisogno concreto di creare qualcosa che rimanesse oltre loro stessi. Oggi, invece, i loro figli – la generazione dei baby boomer – paiono impegnati in una corsa simbolica verso l’immortalità: fondazioni personali, premi intitolati, eventi commemorativi che molto spesso rivelano una spinta a preservare il nome di famiglia più che a rispondere a un reale bisogno sociale.
Ma serve davvero una fondazione per onorare una persona cara? Non sempre. Se il progetto risponde a una reale necessità, promuove crescita collettiva, sostiene giovani talentuosi o offre un servizio utile a chi ne ha bisogno, il nome intitolato diventa davvero uno strumento di bene comune. Viceversa, se la finalità è perpetuare un cognome con iniziative di facciata, si sfiora quella “filantropia narcisistica” in cui il protagonista diventa chi istituisce la fondazione stessa, non il bene che produce.
Le storie di fallimento in tal senso sono numerose. Basti pensare alla Fondazione Breda: nata con intenti benefici, è stata travolta da malagestione e cattivo uso dei fondi, lasciando una scia di occasioni perse e scandali invece che un’eredità positiva. Oppure riflettere sulle molte fondazioni italiane nate negli anni Novanta – spesso prive di sostegno solido o di un vero piano d’azione – che non hanno superato la prova del tempo: la maggioranza di queste, prive di risorse e controllo, sono state chiuse o si sono dissolte senza lasciare alcun contributo concreto. E ancora, alcune fondazioni riconducibili a circoli familiari si sono rivelate strumenti di visibilità personale più che leve di cambiamento sociale, tanto da scomparire dopo pochi anni lasciando soltanto qualche cronaca locale e molte illusioni.
Tutto ciò invita a una riflessione onesta: chi serve, davvero, la fondazione? La comunità oppure l’ego di chi la promuove? È giusto voler ricordare, ma la memoria si onora con sobrietà e utilità sociale, senza cadere nella trappola dell’autocelebrazione travestita da beneficenza. Trasformare la memoria privata in bene collettivo è possibile solo con progetti trasparenti, efficaci, progettati per durare e per rispondere a bisogni reali. Nessuna statua o evento singolo basterà se manca una vera eredità di solidarietà.
Solo così, il ricordo si trasforma in valore: non un monumento all’orgoglio familiare, ma un lascito autentico che parla alla collettività e continua a farla crescere nel tempo.