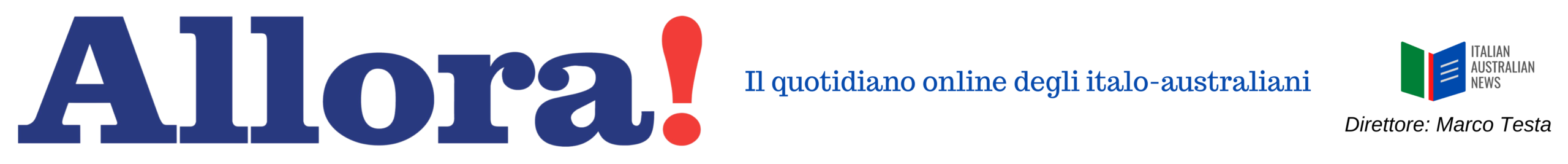Nel suo sorriso c’è la forza di chi ha vinto senza dimenticare, e la dolcezza di chi sa che la vera gloria non è nei trofei, ma nei cuori che hai toccato.
di Guglielmo Credentino
C’è un vento in Basilicata che non dimentica. Soffia tra i campi dorati di Pomarico e porta con sé il profumo dell’erba tagliata, il canto dei grilli, il rumore leggero di un pallone che rimbalza su un cortile di pietra.
È da quel vento che nasce Franco Selvaggi, nel 1953: un bambino minuto, dagli occhi chiari e la corsa vivace, capace di trasformare ogni tratto di strada in un campo da calcio. Le donne lo osservavano ridendo; gli uomini si fermavano a guardarlo con stupore. Quel ragazzo non correva soltanto: danzava col pallone.
Aveva il passo lieve e il coraggio di chi sogna. Cresceva tra i Sassi e i muretti a secco e, in lui, il calcio non era solo gioco: era linguaggio, respiro, libertà.
Alla scuola “Gianni Rivera Matera” imparò la disciplina: sveglia presto, allenamenti sotto la pioggia, rispetto per chi lava le maglie e per chi prepara i palloni. Franco non saltava mai un giorno. Anche quando le scarpe erano vecchie, anche quando il vento tagliava il viso, lui c’era.
Era un ragazzo educato, riservato, sempre pronto a ringraziare. E in quello sguardo pulito i suoi allenatori vedevano già la stoffa del campione: non tanto nel talento, ma nella testardaggine gentile di chi vuole arrivare senza calpestare nessuno.
Poi arrivò la Ternana. La chiamata che cambiò tutto.
Aveva vent’anni e un sogno grande quanto la Murgia. La Serie A lo accolse come si accoglie una promessa: con curiosità e un pizzico di scetticismo. Era minuto, sembrava fragile, ma in campo diventava tempesta. Dalla Ternana alla Roma, la vita di Franco prese ritmo. Capitale, giornali, pressioni, allenatori esigenti. Ma lui rimaneva lo stesso: un ragazzo che non si ubriacava di successo, che preferiva ascoltare, osservare, imparare.
Nel silenzio della sera, mentre la città dormiva, pensava alla sua terra, a Pomarico, alla voce di sua madre che diceva piano: “Franco, ricordati sempre chi sei”. Fu a Taranto, allo stadio Erasmo Iacovone, ex Salinella, che Franco divenne leggenda. Cinque stagioni di sudore e applausi, cinque anni in cui il popolo rossoblù imparò ad amare quel ragazzo che non mollava mai. La domenica, quando lo speaker pronunciava “Selvaggi!”, il boato si mescolava al suono del mare. Taranto era una città operaia, di mani callose e sogni resistenti. E in lui si riconosceva, perché era come loro.
Non un fenomeno costruito, ma un uomo vero, leale, capace di sorridere anche dopo la sconfitta. Le sue giocate facevano alzare gli occhi e battere il cuore.
Ogni gol era una carezza per chi viveva di sacrifici. Ogni corsa, un messaggio: “Ce la possiamo fare”. E poi il destino bussò ancora.
Era il 1979. Dall’altra parte del mare, un uomo chiamato Gigi Riva, “Rombo di Tuono”, lo aveva notato. Riva, che di coraggio e di dolore ne sapeva quanto pochi, riconobbe in Selvaggi una scintilla familiare: la fame, la dignità, il cuore. “Voglio lui”, disse Riva. E fu così che Franco arrivò a Cagliari. Il vento della Sardegna gli ricordava quello di Matera e il popolo sardo lo accolse come un figlio del Sud, trapiantato in un’altra terra fiera. In campo era devastante: corsa, visione, fiuto. Dodici gol in un solo campionato, prestazioni da leader silenzioso. Riva lo seguiva come un fratello maggiore. Gli parlava poco, ma con parole che restavano incise. Gli insegnò che essere campioni non significa solo segnare, ma esserci: per i compagni, per la squadra, per la gente. Selvaggi porterà sempre dentro quella lezione. “A Gigi devo molto”, dirà anni dopo, “mi ha trattato come un uomo, prima che come un giocatore”. Poi arrivò la chiamata che ogni bambino sogna: la Nazionale.
Enzo Bearzot, il saggio del calcio italiano, lo volle con sé. Lo volle non solo per i piedi, ma per l’anima.
Era il 1982. Fanchino partì per la Spagna, portando con sé un pezzo di Basilicata. Non giocò, ma visse quel Mondiale da protagonista silenzioso, con il sorriso e il cuore.
I compagni lo rispettavano, Bearzot lo stimava. E quando il cielo di Madrid si illuminò la sera dell’11 luglio e l’Italia alzò la Coppa del Mondo, anche Franco pianse. Quelle lacrime erano di un uomo che aveva corso tutta la vita per arrivare lì e che ora, guardando il tricolore, sentiva dentro la voce della sua terra: “Ce l’hai fatta, figlio della Murgia”. Selvaggi non fu solo calciatore.Fu allenatore, dirigente, guida. Allenò con rispetto e pazienza, non alzando mai la voce se non per incoraggiare. Credeva che la vittoria contasse, ma non più della crescita umana.
“Il calcio è scuola di vita”, ripeteva. “Ti insegna a perdere con dignità e a vincere con rispetto”.
Le panchine che sedette portarono la sua impronta: ordine, tutela del talento giovane, attenzione al carattere oltre alla tecnica. Il suo stile da allenatore rifletteva il calciatore che era stato: mai esibizionista, sempre al servizio degli altri.
E così nacque la sua scuola calcio, a Matera. Non una semplice accademia, ma un gesto d’amore verso i bambini che, come lui, un giorno rincorrevano sogni più grandi delle scarpe che indossavano. Ogni allenamento è un atto di educazione, ogni sorriso un insegnamento. Franco segue i ragazzi con la stessa luce negli occhi che aveva a vent’anni. Insegna il dribbling, ma soprattutto insegna la gratitudine. Dice ai suoi allievi: “Non importa quanto sei alto, importa quanto credi in te”. E ogni volta che un bambino segna un gol e alza le braccia al cielo, c’è dentro quella gioia un frammento di Pomarico, un’eco lontana del piccolo Spadino che non ha mai smesso di sognare. Franco Selvaggi è più di un campione del mondo. È il simbolo di un Sud che sa alzarsi, che sa credere, che non mendica ma dimostra. È la voce di Matera che si fa strada tra le città del calcio, portando con sé la dignità di un popolo.
Nel suo sorriso c’è la forza di chi ha vinto senza dimenticare e la dolcezza di chi sa che la vera gloria non è nei trofei, ma nei cuori che hai toccato. E quando il sole tramonta sui Sassi, sembra ancora di vederlo: un uomo in maglia azzurra.
(La Voce di Matera)