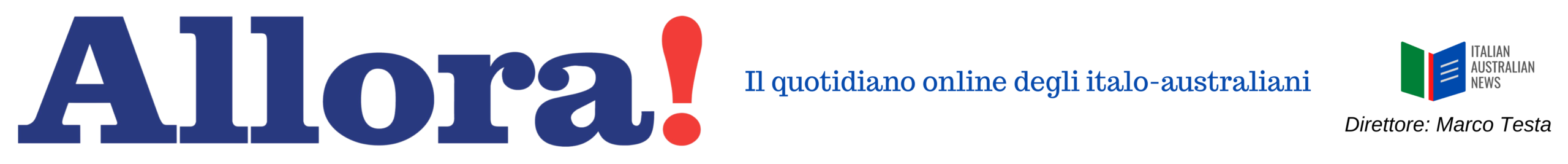di Luigi De Luca
C’è un momento, nel silenzio del laboratorio, in cui il gelato parla. Non a parole, ma con il linguaggio sottile degli aromi, delle temperature, degli incontri inattesi.
Lì, tra un pistacchio siciliano e un cardamomo indiano, si consuma una piccola rivoluzione. L’incontro di identità diverse che non si annullano, ma si rispettano.
L’integrazione è come mantecare. Serve tempo. Serve ascolto. Serve un movimento che non violenta, ma accoglie. Ma attenzione, non si tratta di far scomparire il sapore dell’uno per far vincere quello dell’altro. Il rischio è proprio lì. In quel mescolare troppo, nel voler uniformare, si perde l’anima del gusto, e con essa l’identità.
È questo il doppio taglio dell’integrazione. Da una parte, l’urgenza di essere parte di una comunità nuova, di costruire un ponte verso chi ci ospita. Dall’altra, il timore che quel ponte diventi una strada a senso unico, e ci porti via da chi siamo sempre stati.
Chi lascia la propria terra, spesso, porta con sé sapori e profumi che non si vedono, ma che custodiscono storie. La lingua dei nonni, le feste di paese, il modo di impastare, il nome delle cose.
Se, per integrarsi, deve rinunciare a tutto questo, è come se gli si chiedesse di togliersi il cuore per sembrare “normale”.
Ma se invece l’integrazione diventa dialogo, allora sì che nasce qualcosa di nuovo e potente: un sorbetto all’ibisco che racconta l’Africa, una crema al riso e zenzero che profuma di Asia, un cioccolato che ha attraversato gli oceani.
Fondersi senza sparire. Essere accolti senza essere cambiati. Portare il proprio sapore al mondo, senza doverlo tradire. Il Gelato e’ linguaggio sociale. È atto politico.
È memoria che resiste alla semplificazione, alla traduzione forzata. E allora la sfida, anche fuori dal laboratorio, è la stessa: creare un mondo in cui si possa convivere senza doversi annullare.
Un mondo dove si possa dire “io sono” e allo stesso tempo dire “noi siamo”. L’integrazione è un equilibrio delicato, e può diventare un’arma a doppio taglio.
Da un lato, integrare significa imparare la lingua, conoscere le regole della società in cui si vive, partecipare alla vita sociale, contribuire.
È un processo necessario per la convivenza. Ma dall’altro lato, se questo processo diventa assimilazione forzata, o se si sente il bisogno di rinunciare alle proprie radici per essere accettati, allora c’è un prezzo troppo alto da pagare: la perdita dell’identità culturale. Il rischio è quello di diventare “invisibili”, non più né della terra d’origine né della nuova patria.
E questo accade anche ai figli di migranti, che a volte si sentono “stranieri ovunque”. L’integrazione dovrebbe essere invece un dialogo.
Un arricchimento reciproco. Non il monologo della cultura dominante. Un gelato alla menta può parlare con un sorbetto di tamarindo, credo proprio di no?
Forse il vero successo dell’integrazione è quando non c’è bisogno di scegliere tra “essere accettati” e “restare se stessi”. Quando la società accoglie senza annullare. Ma per questo, siamo ancora troppo lontani.